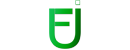L’inizio della storia del colosso siderurgico Ilva, prima delle note vicende legate allo stabilimento di Taranto, risale al luglio del 1904 quando fu varata la legge per il risorgimento economico di Napoli. Il legislatore stabiliva la creazione, entro il 1908, di un imponente impianto a ciclo integrato a Bagnoli. Attraverso la fornitura di minerale di ferro a prezzo agevolato e con la creazione di forti barriere doganali che penalizzavano la concorrenza estera, lo Stato cavalcò l’onda di una tendenza che stava nascendo nel Paese. Erano anni in cui si stabilirono rapporti di reciprocità e complementarietà di interessi tra i vari centri produttivi della società, fino alla nascita della Società Anonima Ilva nel 1905 e, nel 1911, del Consorzio Ilva, attraverso il quale le Società Elba, Alti Forni, Fonderie e Acciaierie di Piombino, Ferriere Italiane, Siderurgica di Savona e Ligure Metallurgica, affidano a Ilva la gestione dei loro stabilimenti. Con lo scoppio del primo conflitto bellico mondiale, incrementa il fabbisogno di prodotti siderurgici e diviene ancora più stretto il legame tra i partner del Consorzio; ciononostante, le due crisi economiche degli anni ’20, inducono la Banca Commerciale Italiana a rilevare la proprietà dell’Ilva, insieme ad altre imprese siderurgiche minori. Il 2 luglio 1937 l’IRI costituisce la Società Finanziaria Siderurgica – Finsider al fine di gestire in modo efficiente il patrimonio economico e finanziario dell’Ilva e delle sue controllate e partecipate. All’indomani della seconda guerra mondiale, nel grembo delle risorse economiche provenienti dal piano Marshall, l’Iri e la Finsider promuovono la riconversione delle attività, adeguando la produzione alle nuove necessità sociali. Le opere per la ricostruzione, lo sviluppo dell’industria automobilistica e la riduzione dei costi di produzione, ispirano un imponente programma impiantistico, basato sulla costruzione del nuovo polo siderurgico di Taranto, sul complesso di laminazione a freddo di Novi Ligure e sul rinnovamento del centro di Bagnoli.
Intorno alla metà del 1959, in un contesto politico incandescente, si riafferma il primato dell’iniziativa politica nelle scelte economiche: attraverso la Cassa per il Mezzogiorno e il Ministero dei Lavori Pubblici, lo Stato si fa carico delle spese per le infrastrutture e viene autorizzato un aumento del fondo di dotazione per l’Iri da destinare al centro di Taranto. I lavori per la costruzione iniziano nel 1960 mentre la sua messa in funzione è complementare ad un accordo riservato tra URSS, ENI e Finsider: trattasi di un contratto che prevede dal 1961 una ingente fornitura di greggio dall’Unione Sovietica in cambio di tubi saldati. Tra il 1962 e il 1964 viene completato l’intero stabilimento con l’altoforno, l’acciaieria, il laminatoio a caldo e gli impianti marittimi, nei tempi previsti ma con un forte incremento dei ritmi produttivi, imponendo il tributo di un elevato numero di infortuni sul lavoro. Il 24 ottobre 1964, l’allora Presidente del Consiglio Aldo Moro, accompagnato dalle altre autorità, assisteranno all’accensione del primo altoforno[3]. Sul finire degli anni ’60 e la prima metà degli anni ’70, la grande espansione della domanda di acciaio porta ad un grande incremento dell’attività produttiva e all’allargamento del polo siderurgico tarantino. Ironia della sorte, proprio nell’anno in cui culmina il processo di ingrandimento, il consumo mondiale diminuisce dell’8% e quello della Comunità Europea del 18%. Oltre al danno economico-finanziario, la beffa: a Taranto cominciano ad affiorare i rischi ambientali e per la salute dei cittadini, date le enormi dimensioni raggiunte dall’insediamento industriale. Il 31 maggio 1980 la Comunità Europea dichiara lo stato di crisi manifesto per il settore, di fronte al crollo della domanda globale viene imposto un programma di chiusure. Così nel 1988 Finsider e Italsider furono messe in liquidazione e scomparvero, lasciando il posto alla rinata Ilva. Bassa produttività, diseconomie di scala ed errori gestionali contribuiscono, insieme ai fattori economici esterni, ad aggravare il quadro e del vecchio gruppo di poli produttivi presenti nella penisola, l’unico a restare in piedi oltre a quello ligure, resta quello sulle rive dello Ionio.
Nonostante la spinta iniziale, data dal buon esito in termini di efficientamento, del piano Nippon Steel, il ciclo espansivo dell’Ilva di Taranto si arresta in maniera irreversibile con la flessione dei prezzi dei prodotti siderurgici, lasciando sul tavolo i danni all’ecosistema. È in questo frangente storico che torna necessaria la strada della privatizzazione. Nel 1994 iniziano le trattative per la cessione e la contesa vede protagonisti da un lato, la cordata composta dalla British Steel Corporation, dal gruppo Lucchini e dalla società francese Usinor, e dall’altro, il banchiere statunitense Miller in accordo con il gruppo Riva ed alcuni investitori di Taranto e Novi Ligure. Per un ammontare totale stimato intorno ai 1649 miliardi di lire, nel 1995 il colosso acciaieristico italiano ed europeo viene ceduto alla Rilp spa, controllata dal gruppo Riva e nella quale figuravano come soci di minoranza, tra gli altri: il gruppo indiano Essar, i fratelli Farina della Metalfar di Erba, ed un gruppo di banche pubbliche. I Riva sono investiti dell’arduo compito di rilancio dell’azienda, ma in breve tempo si trovano a fare i conti con problemi seri di inquinamento della città collegati alla sua area industriale: il numero dei decessi per tumore registrati nella zona comincia a diffondere sospetti. Già nel 2012 la magistratura tarantina dispone il sequestro dell’acciaieria per gravi violazioni ambientali. Vengono disposte le misure cautelari per alcuni indagati nell’inchiesta per disastro ambientale a carico dei vertici aziendali: tra questi anche Emilio Riva, presidente dell’Ilva Spa fino al maggio 2010 e il figlio e suo successore Nicola Riva. Il gip scrive che l’impianto è stato causa – e continua a esserlo – di “malattia e morte” perché “chi gestiva e gestisce l’ILVA ha continuato in tale attività inquinante con coscienza e volontà per la logica del profitto, calpestando le più elementari regole di sicurezza“.
Fu a questo punto che il Governo guidato da Mario Monti, per sbloccare dai sequestri gli impianti sottoposti a lavori di risanamento e garantire così la tutela dei posti di lavoro degli operai, emanò il 3 dicembre 2012 un decreto legge che autorizzava la prosecuzione della produzione dell’azienda. Nel mese di maggio 2013 il gip Patrizia Todisco dispone un maxi-sequestro da 8 miliardi di euro sui beni e sui conti del gruppo Riva, ma proprio sullo scorcio dello stesso anno l’ordinanza viene annullata dalla Corte di Cassazione su ricorso dei Riva (nel frattempo però, a pochi giorni dal provvedimento del gip, i Riva lasciano il consiglio di amministrazione dell’azienda). Ai primi di giugno interviene nuovamente il governo e, con un decreto, commissaria l’Ilva: sarà Enrico Bondi, poi affiancato da Edo Ronchi ad avere per un anno in mano le redini del colosso tarantino, giacché successivamente, i due vengono sostituiti da Piero Gnudi e Corrado Carrubba. Durante la permanenza a Palazzo Chigi del segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, nel gennaio 2015 l’acciaieria, attraverso una legge, passa in regime di amministrazione straordinaria e i commissari diventano tre: a Gnudi e Carrubba si affianca Enrico Laghi. Il 4 gennaio 2016 il Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi, da il via all’iter per l’assegnazione ai privati dell’acciaieria del quartiere Tamburi di Taranto, con la firma del decreto per autorizzare la cessione di Ilva.
Il giorno successivo viene pubblicato il bando di gara con l’invito a manifestare interesse, fissando il termine ultimo in 30 giorni a partire dal 10 gennaio. Allo scadere del tempo utile, sono in tutto 29 le risposte presentate e fra i nomi dei possibili acquirenti spiccano Arvedi, Marcegaglia, Arcelor Mittal e il gruppo carioca Csn Steel. In seguito alle vicende giudiziarie legate alla c.d. inchiesta Tempa Rossa, che porteranno alle dimissioni dell’allora Ministro in carica Federica Guidi, avviene un avvicendamento al dicastero di Via Molise: sarà il neo Ministro Carlo Calenda ad avere l’onere di condurre in porto la gara per l’assegnazione dell’Ilva al miglior offerente. Sarà proprio il nuovo inquilino del Mise a concedere ancora 18 mesi agli stakeolders in gara per modificare ed integrare il piano ambientale, a testimonianza, ancora una volta, di quanto complicata sia la risoluzione di una vicenda in cui, il bilanciamento degli interessi in gioco poggi su di un equilibrio troppo precario. Il 30 giugno 2016 – termine ultimo per la presentazione delle “offerte iniziali” – restano solo due cordate a nella partita l’aggiudicazione della gara: da un lato, Am Investco con Ancelor Mittal all’85% e Marcegaglia al 15%, mentre dall’altro Acciaitaliacomposta da tutti soci italiani. Nel frattempo, nel decreto milleproroghe di fine anno, il Governo provvederà ad allungare ulteriormente i tempi per l’ultimazione del Piano ambientale, che slitta al 2023. Il 6 marzo 2017 scade il termine utile per la presentazione delle “offerte vincolanti”, mentre alla cordata italiana si affianca il colosso siderurgico indiano JSW guidato dall’imprenditore Saijan Jindal. Sarà proprio quest’ultimo, insieme a Leonardo Del Vecchio, a mettere sul tavolo del ministro Calenda un rilancio sul prezzo di offerta, quando ormai fuori tempo massimo, il 26 maggio 2017 i commissari straordinari proporranno al Ministero di via Molise la loro soluzione, optando in favore della cordata ArcelorMittal riunita nella joint-venture Am Investco. Dopo pochi giorni, il 5 giugno 2017 dal Mise arriva il via libera con la firma del decreto di assegnazione della gara ad ArcelorMittal. Quella che venne valutata come migliore offerta prevedeva i seguenti numeri: 1,8 miliardi per l’acquisizione, 2,3 miliardi di investimenti, 8 milioni di tonnellate di produzione, 9,5 miliardi di spedizioni portando a Taranto una quota di semilavorati dall’estero. Nota stonata, il nodo occupazionale: il vincitore della gara parte con 9.407 addetti su 14.200 con l’obiettivo di assestarsi, nel 2024, a quota 8.480, scatenando ovviamente l’ira dei sindacati.
All’indomani delle elezioni politiche del 2018 che registrano il boom del MoVimento 5 Stelle e l’ascesa della Lega, al vertice del Mise giunge il trentunenne Luigi Di Maio, pedina fondamentale nello scacchiere del c.d. “Governo del cambiamento”. Sarà il leader pentastellato di Pomigliano a dover gestire l’annosa questione Ilva, tenendo in conto quanto ormai già prodotto dal suo predecessore circa un anno addietro. Sul finire del mese di luglio scorso, Arcelor Mittal ha presentato al Mise la tanto attesa integrazione al piano industriale originario, ossia quello che venne messo sul tavolo dell’ex ministro Calenda. Questo primo step ha di fatto registrato un esito negativo, ragion per cui il nuovo ministro ha deciso di non dare il via libera definitivo al passaggio di proprietà dell’acciaieria. Le richieste del vicepremier vanno in una direzione precisa e sicuramente alzano la posta in gioco, tanto è vero che in seguito ai pareri dell’Anac, circa le irregolarità riscontrate nella gara per l’assegnazione dell’acciaieria, il leader grillino ha addirittura minacciato l’annullamento della gara, mentre lo scorrere del tempo avvicina la scadenza della gestione commissariale prevista per il 15 settembre 2018. Nodo cruciale della trattativa la questione ambientale: le pretese del ministro conducono alla riduzione di emissioni di CO2 per tonnellata di acciaio liquido, oltre ad un azzeramento delle polveri. Inoltre, si chiede alla controparte uno sprint alla produzione mediante l’impiego di processi di produzione a basso utilizzo di carbone; si chiede all’azienda franco-indiana l’impegno a elaborare e trasmettere ogni due anni, uno studio di fattibilità in merito all’implementazione presso lo stabilimento di Taranto di processi di produzione alimentati a gas naturale. Ancora, si chiedono tempi più brevi per la copertura dei parchi minerari, al fine di eliminare il prima possibile queste fonti inquinanti nonché gli eventi critici che si verificano durante i c.d. “Wind Days”. Tra le specifiche richieste figurano anche la questione del rapporto tra AncelorMittal ed i fornitori, con la liquidazione dei debiti nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
C’è poi il capitolo dedicato all’economia circolare, e dunque il risparmio in termini di approvvigionamento. Ancora, la riduzione delle quote di acqua dolce e marina per il ciclo produttivo e l’operazione trasparenza nella gestione attraverso la logica dell’apertura della fabbrica a visite guidate, per un Ilva aperta a tutti. Infine, spazio alle consultazioni con i rappresentanti delle comunità locali con cadenza almeno semestrale per comprenderne priorità è preoccupazioni e pubblicazioni periodiche con cadenza almeno annuale di rapporti per rendere noti i progressi effettuati dall’affittuario nel raggiungimento dei propri obiettivi ambientali e industriali. Ma il vero punto di svolta dell’intricata vicenda sarà determinato dalla questione dei posti di lavoro. La bozza di intesa partorita sul tavolo dell’ex ministro Calenda il 10 maggio scorso, e subito osteggiata dalla maggioranza dei sindacati, prevedeva 10.000 assunzioni, di cui 1.200-1.500 addetti travasati nella società mista Ilva-Invitalia (quest’ultima controllata dal Ministero dell’Economia e del Tesoro) che avrebbe fatto un pezzo di bonifiche e altre attività, mentre il resto – circa 2.000 lavoratori – smaltiti attraverso gli esodi volontari, agevolati e incentivati. L’allora vertice del Mise assicurava zero esuberi alla fine del percorso, in ragione del fatto che tutti avrebbero beneficiato di protezione o comunque di una ricollocazione sul mercato. Troppo poco per i sindacati che rivendicavano maggiori tutele e un numero superiore di assunzioni. Nella fase conclusiva del negoziato – gestita da Luigi Di Maio – la nuova proposta di Mittal partiva da un numero di occupati più alto: circa 10.300, dunque un primo miglioramento rispetto alla situazione precedente. Ma il connubio di forze tra Mise e sindacati ha portato ad alzare l’asticella delle rivendicazioni. Al culmine della trattativa, non solo verrà confermata la tutela dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (bypassando il regime previsto dal jobs act) ma la cordata accoglierà le richieste della controparte e si chiuderà per quota 10.700 occupati, circa 700 unità in più rispetto alla bozza Calenda. Dopo il tavolo del 5 settembre 2018 tra Mise, sindacati e Arcelor Mittal, il rebus Ilva di Taranto sembra aver preso una direzione consona alle esigenze e alle aspettative di molti lavoratori impiegati nel settore siderurgico pugliese, ma allo stesso tempo, sono state registrate le aspre critiche e la delusione di quanti auspicavano la dismissione del polo acciaieristico del quartiere Tamburi e l’avvio di una riconversione economica dell’area tarantina. Nel momento in cui si scrive sono in corso i referendum tra i lavoratori degli stabilimenti Ilva, per l’approvazione dell’accordo con Arcelor Mittal. Gli interessi contrapposti e il difficile bilanciamento dei diritti da tutelare restano ancora nel grembo della comunità cittadina di Taranto, in quella che è stata e probabilmente ancora sarà una storia infinita, in cui a contendersi l’altare della politica ci sono ancora i due protagonisti di un secolo fa: il cuore e l’acciaio
Autore: Luigi Pone
link al blog di Ius in Itinere
La storia infinita dell’Ilva di Taranto: tra diritti ed economia